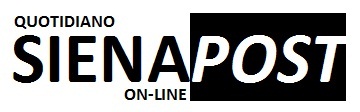Riceviamo e pubblichiamo in anteprima un articolo di Cristina Di Silvio che sarà pubblicato sul prossimo numero del mensile di economia e finanza “Leasing Time Magazine” diretto da Gianfranco Antognoli. L’autrice è Responsabile della Direzione Relazioni Istituzionali Estere del SIRIP – Sindacato dei Rappresentanti degli Interessi Parlamentari presso la Camera dei Deputati e Parlamento Europeo. La rivista “Fortune Italy” l’ha inserita in una lista delle 50 donne più influenti d’Italia per il 2024.
Nel 2025, l’economia italiana si colloca in una fase di attrito strutturale persistente, caratterizzata da un disallineamento crescente tra condizioni macroeconomiche reali e contesto finanziario. Tale divaricazione è alimentata da un insieme eterogeneo di fattori esogeni ed endogeni che si combinano in modo non lineare, generando un regime di elevata incertezza e ridotta visibilità prospettica. In particolare, le tensioni geopolitiche (conflitti in Ucraina e Medio Oriente), la frammentazione commerciale globale (asse USA–Cina e politiche di reshoring europeo) e il permanere di condizioni monetarie restrittive da parte della BCE (tasso sui depositi al 2,25%, tasso di rifinanziamento principale al 2,40%) costituiscono un insieme di forze pro-cicliche che, sommandosi alla lenta digestione degli shock pandemici e inflattivi, continuano a comprimere la crescita potenziale. Il prodotto interno lordo reale è previsto in aumento dello 0,7% per l’anno, un dato significativamente inferiore sia alla media storica sia ai benchmark dell’area euro.
Tale dinamica riflette una crescita eccessivamente dipendente dalla spesa pubblica, in larga parte legata agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui efficacia è però ridimensionata da vincoli burocratici, ritardi attuativi e carenza di capacità amministrativa. La domanda interna, soprattutto privata, è in indebolimento, a causa dell’inflazione core al 2,6%, sostenuta da rigidità strutturali nei settori energia, trasporti e servizi. La stagnazione del reddito reale disponibile limita i consumi, la produttività del lavoro è stagnante e l’allocazione del capitale mostra segni di inefficienza. Ne risulta un contesto di stagnazione endogena, privo di una chiara traiettoria di trasformazione industriale.
Sul fronte estero, l’Italia mostra le tipiche vulnerabilità di un’economia altamente esposta alle catene globali del valore. Il calo della domanda cinese (–14% dell’export verso Pechino) colpisce settori ad alto valore aggiunto come meccanica strumentale, componentistica avanzata e beni industriali premium. A questo si aggiunge un elemento di forte instabilità proveniente dagli Stati Uniti: a partire dal 1° agosto 2025, l’amministrazione americana introdurrà un dazio del 30% su tutti i beni esportati dall’UE, con l’obiettivo dichiarato di ridurre un “deficit commerciale strutturale e insostenibile”. La misura, annunciata in una comunicazione ufficiale alla Commissione Europea, rappresenta un passaggio deciso verso un nuovo paradigma protezionista, subordinando l’accesso al mercato USA alla delocalizzazione produttiva sul suolo americano. La logica bilaterale proposta da Washington, che punta a una reciprocità piena, implica una riformulazione della diplomazia economica transatlantica su basi transazionali.
Per l’Italia, ciò comporta una doppia pressione: da un lato, la penalizzazione immediata di comparti chiave (meccanica, moda, agroalimentare); dall’altro, una spinta alla rilocalizzazione industriale per aggirare i dazi. Il protezionismo selettivo e la volontà americana di facilitare investimenti produttivi sul proprio territorio minano la tenuta delle supplychain europee, rischiando una fuga selettiva di investimenti verso gli USA. L’instabilità nei mercati mediorientali e la proliferazione di barriere commerciali nei rapporti triangolari USA–UE–Asia impongono alle imprese italiane una ristrutturazione delle catene di fornitura e dei modelli distributivi, realizzabile solo da operatori con adeguata scala operativa e patrimonializzazione.
Sul piano bancario, il sistema creditizio nazionale mantiene una relativa solidità, grazie a margini di interesse in espansione, riduzione dei crediti deteriorati e rafforzamento patrimoniale (Tier 1). Tuttavia, persiste una vulnerabilità sistemica legata all’elevata esposizione ai titoli di Stato domestici (circa il 22% degli attivi bancari), che espone il settore a rischi di rivalutazione del debito e a un possibile riemergere del differenziale di rischio sovrano. Lo spread BTP–Bund, stabilizzato ormai da diverse settimane sotto i 100 punti base (con un minimo recente di 90), riflette in larga parte il sostegno implicito fornito dalla BCE tramite i reinvestimenti del programma PEPP, più che una riduzione strutturale del rischio percepito. Il credito netto al settore privato si contrae in termini reali, con una trasmissione disfunzionale soprattutto verso le piccole e medie imprese (PMI), ancora dipendenti dal canale bancario tradizionale e con accesso limitato al mercato dei capitali.
Sui mercati finanziari, l’Italia continua a subire una sottoponderazione nei portafogli internazionali, a causa di una combinazione di fattori strutturali: bassa capitalizzazione media, liquidità ridotta, opacità nei meccanismi di governance e un framework regolamentare incompleto rispetto agli standard dell’Unione dei Mercati dei Capitali. Tuttavia, tali inefficienze generano asimmetrie informative e di pricing che aprono spazi per opportunità selettive, in particolare: nel comparto infrastrutturale regolato (energia, digitalizzazione, reti intelligenti); tra le mid-cap manifatturiere con forte vocazione export; nei settori difensivi ad alta resilienza (farmaceutico, energia, difesa).
Il mercato del private equity mostra dinamiche relativamente vivaci, ma è limitato da un deal flow contenuto e dalla sottocapitalizzazione cronica dell’ecosistema tech e deep innovation. In questo scenario, l’Italia si configura come un laboratorio di disallineamenti sistemici, dove il rischio percepito a livello sovrano non sempre riflette i fondamentali industriali reali, creando margini per strategie di arbitraggio tra rischio apparente e rischio effettivo. Le strategie allocative più coerenti risultano essere: quelle infra-cicliche, focalizzate su asset regolati a rischio definito; approcci equity long-short, concentrati su emittenti domestici con beta geopolitico elevato ma bilanci solidi.
All’interno dell’area euro, l’Italia mantiene una natura ibrida: non più “periferia” in senso stretto, ma ancora lontana dal nucleo continentale. È un’economia avanzata per complessità industriale, ma fragile nella trasmissione fiscale, nella governance e nella capacità di attrarre capitali produttivi.
L’assenza di una strategia industriale unificata, l’insufficiente profondità del mercato dei capitali e la mancanza di strumenti di capitalizzazione stabile rischiano di innescare un regime di stagnazione strutturale. Non si profila una crisi acuta, ma un equilibrio deteriorato, in cui bassa crescita, elevata spesa pubblica e debolezza imprenditoriale si autoalimentano come tratti sistemici.
In questo contesto di “policrisi” a bassa trazione endogena, è necessario attivare un dispositivo coordinato di politica industriale, con l’obiettivo di:
- rilanciare la produttività totale dei fattori;
- riequilibrare la struttura del capitale;
- rafforzare l’intermediazione finanziaria alternativa.
Una strategia coerente dovrebbe articolarsi su tre assi principali:
- Incentivi permanenti alla ricapitalizzazione delle PMI, mediante strumenti fiscali pro-equity e veicoli di co-investimento pubblico-privati, focalizzati su high-tech e manifattura avanzata;
- Rafforzamento dell’architettura dei mercati dei capitali, attraverso la creazione di segmenti dedicati alle mid-cap industriali esportatrici, con semplificazioni normative e regimi fiscali specifici;
- Promozione di piattaforme industriali integrate orientate al reshoring strategico e alla manifattura duale, sostenute da partenariati infrastrutturali in ambiti chiave come digitalizzazione, logistica intelligente e autonomia tecnologica.
Tali misure dovranno essere sostenute da una fiscalità di sviluppo coerente e da un sistema di valutazione ex ante dell’efficacia allocativa degli investimenti pubblici, basato su criteri di moltiplicatore economico, spillover tecnologico e resilienza sistemica. Solo una simmetria rinnovata tra governance industriale e struttura dei capitali potrà permettere all’Italia di uscire dalla trappola della stagnazione e convergere verso un equilibrio competitivo e sostenibile, pienamente integrato nelle traiettorie produttive europee.
Cristina Di Silvio